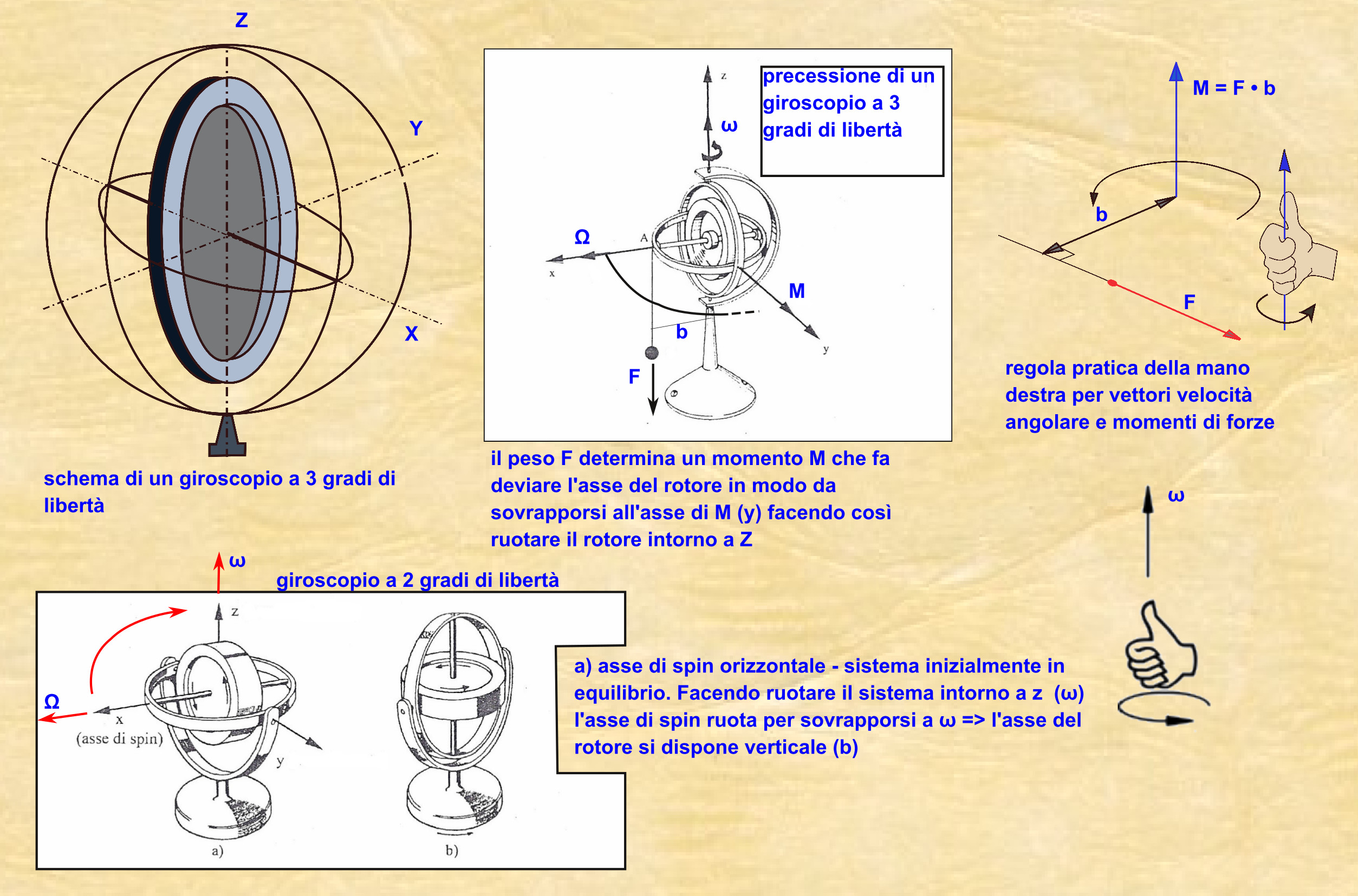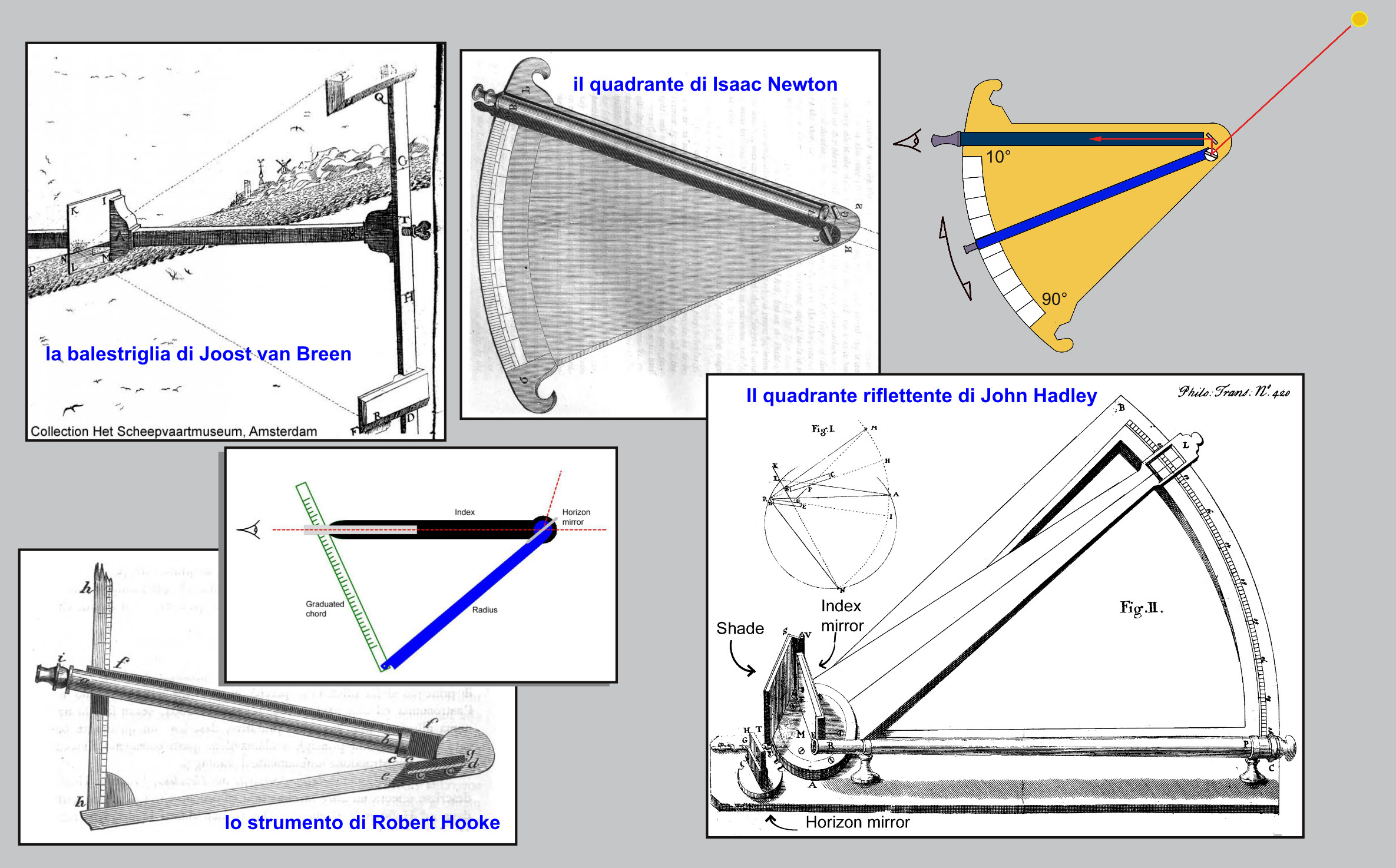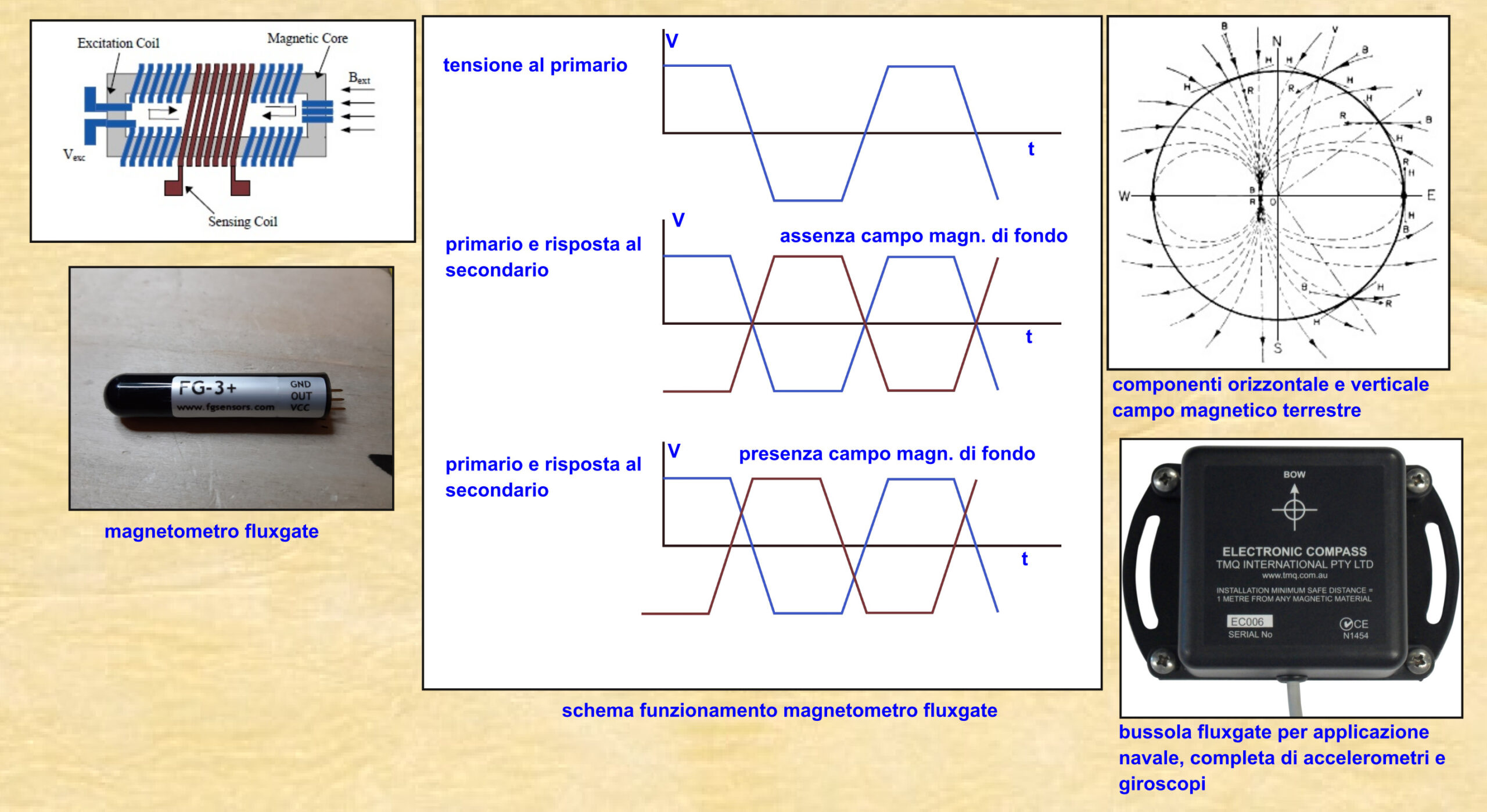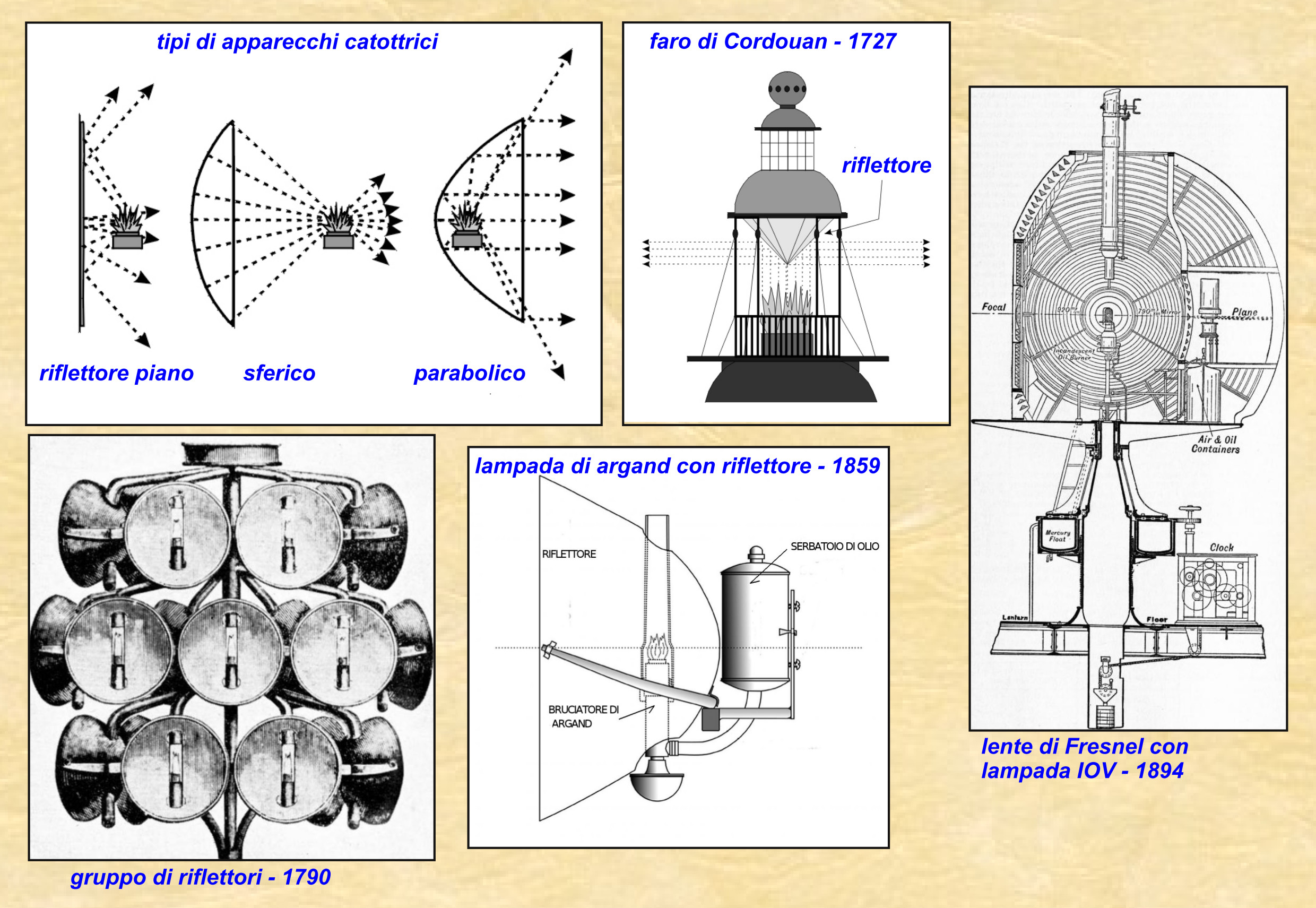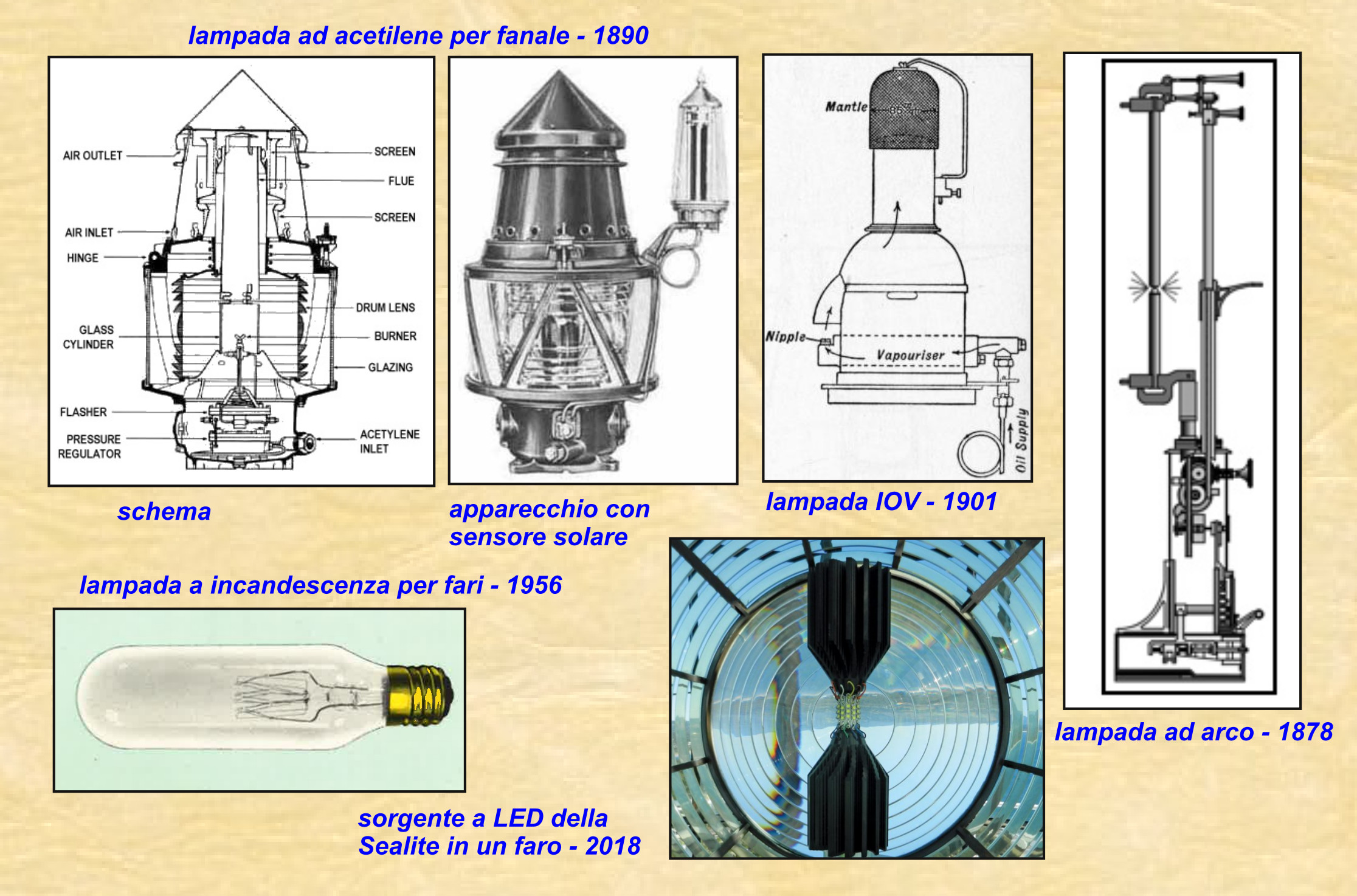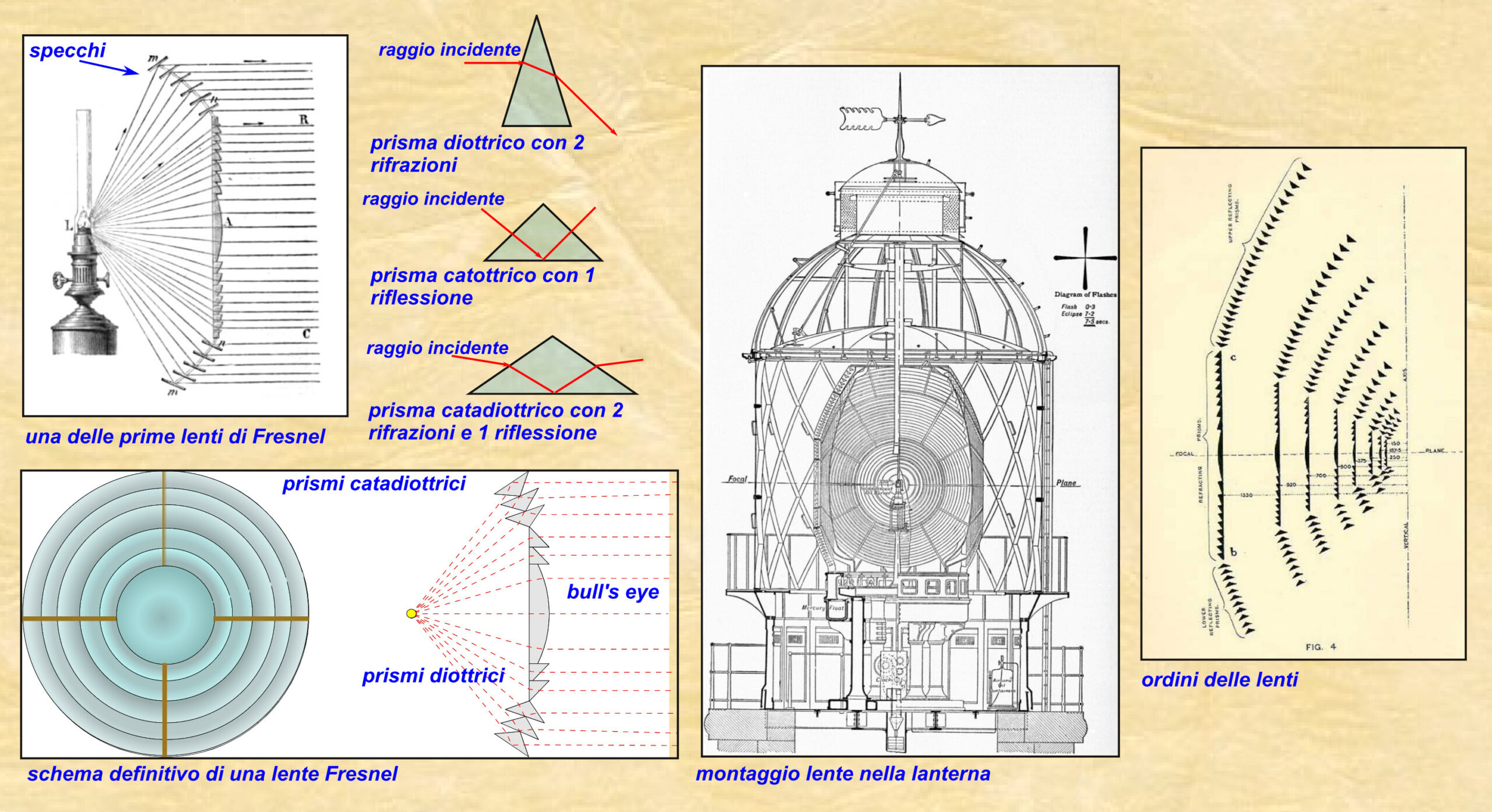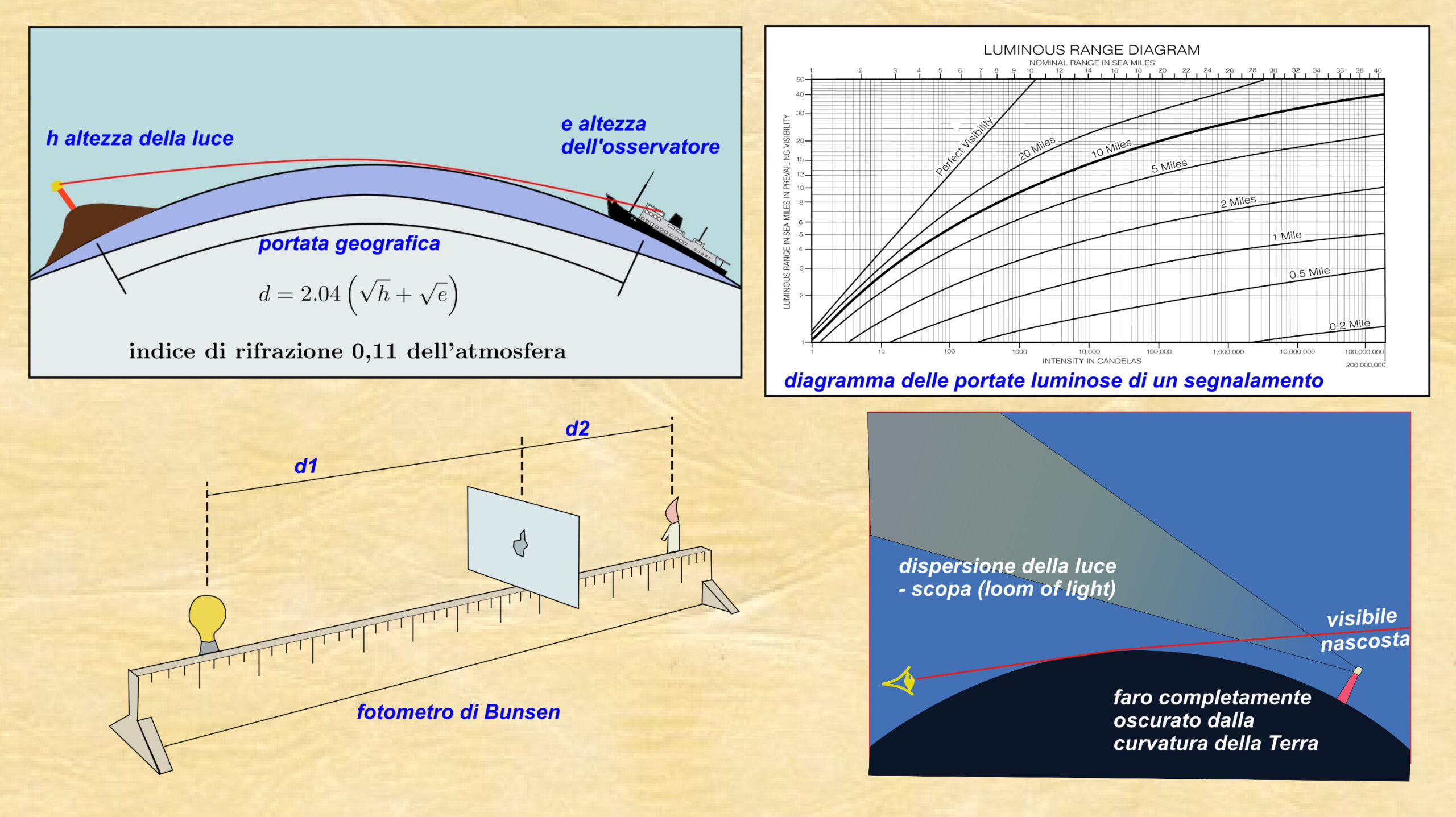Dopo il lungo periodo dei peripli, con il loro contenuto narrativo dominante sulle informazioni nautiche, fatta eccezione per lo Stadiasmo o Periplo del Mare Grande, datato intorno alla metà del I sec. d.C., in cui il termine stadiasmo ha il significato letterale di “misura per stadi” che sostituisce le antecedenti valutazioni delle distanze in giornate, l’intensificarsi degli scambi economici tra le aree opposte del Mediterraneo, gli spostamenti su mare sotto la spinta delle Crociate e l’affermarsi di alcune città mediterranee come potenze navali, tra cui Genova e Venezia, diede un impulso alla produzione di una nuova documentazione nautica, il portolano o portulano, un nuovo termine coniato nel Medioevo come portolanus, “relativo al porto”, derivato dal latino portus, porto. Elementi distintivi rispetto ai peripli erano una maggiore presenza di informazioni sulle distanze, espresse in stadi o in miglia e sulle direzioni, conseguenza del perfezionamento della bussola magnetica, ma anche descrizioni delle coste ed altre notizie utili al navigante. Non a caso in origine il termine portolano era sinonimo di pilota, colui che guida la nave nell’entrata dei porti.
Il più antico portolano finora conosciuto è il Compasso da Navigare, scoperto e studiato dallo storico dell’antichità classica e geografo Bacchisio Motzo (1883-1970) che pubblicò i risultati del suo lavoro nel 1947 (il testo è stato riproposto nel 2012 dalla linguista Alessandra Debanne con un nuovo e più ricco corredo informativo tra cui un ampio glossario).
Di autore ignoto, probabilmente realizzato in Toscana, fu scritto in volgare (non sempre di facile interpretazione per il linguaggio stringato e gergale) e pubblicato in più edizioni, la prima delle quali si fa risalire al 1250.
Partendo da Gibilterra e procedendo in senso orario come nei peripli, vengono descritte le coste del Mediterraneo con indicazione dei porti e punti notevoli. Sono riportate sia le distanze, espresse in miglia (corrispondente a un valore valutato dagli studiosi compreso tra 1230 e 1280 metri).
Sul Compasso, come d’altra parte su tutta la produzione documentale nautica del Medioevo, vi sono ancora molte aree oscure che originano opinioni diverse da parte degli studiosi come ad esempio l’effettivo uso a bordo di documenti come le carte e i portolani.
Per dare un’idea del contenuto di un portolano riportiamo una delle tante istruzioni nautiche del Compasso:
Da lo dicto Taolato a lo capo de Solso xx millara per lo maestro ver lo ponente pauco.
Et guardate a lo ‘ntrare dentro d’una sacca plana que à entorno x palmi, et è dentro entorno ij millara per la via sopredicta, all’altra ponta appresso Taolato, denamti dericto a questa segonna ponta entorno j millaro en mare.
[Dal detto capo Teulada a capo Sulcis 20 miglia in direzione maestrale, un pò verso ponente (all’incirca 320°). Attenzione a non entrare in una secca piana che arriva a pescare fino a 10 palmi e si estende fino a circa due miglia nella direzione detta, dalla seconda punta dopo Teulada fino a circa un miglio davanti a questa punta].
Tra il XV e il XVI secolo furono prodotti numerosi portolani:
nel 1490 ne fu pubblicato uno a Venezia attribuito al mercante e navigatore veneziano Alvise Da Mosto (1429-1483). Noto come Portolano del mare o portolano Rizo, dal nome dell’editore Bernardino Rizo di Novarra, rappresenta uno dei primi esempi di documenti nautici a larga diffusione e con progressivi miglioramenti.
Con la fine del Medioevo i portolani (in fr. portulan, ingl. portolan) furono impiegati, con diverso nome, da altre nazioni europee, primi i francesi con Le Grant Routtier et pilotage de la mer di Pierre Garcie (1430?-1502), considerato il primo idrografo francese, pubblicato la prima volta nel 1483 quindi integrato e aggiornato fino al 1643. In Francia il portolano è così chiamato routtier, un termine da cui discende l’inglese rutter e il portoghese roteiro.
Intorno al 1584 l’olandese Luca Jans Loon Waghenaer pubblicò una raccolta di documenti nautici, noti come Waggoners, comprendenti nozioni di navigazione, tavole, carte, istruzioni di navigazione sui mari d’Europa. Il grande successo spinse l’editore a pubblicarlo in varie lingue: l’edizione inglese aveva come titolo The Mariners Mirror, un’espressione che vorrebbe restituire al lettore, come fa uno specchio. lo spazio rappresentato. L’edizione uscì pochi mesi dopo la battaglia navale che vide gli inglesi sconfiggere la Invincible Armada, una impresa resa possibile anche per l’impiego intensivo dei Waggoners.
Un’altra produzione di documenti nautici in tale periodo storico furono gli isolari, descrizioni accompagnate da disegni di isole ed arcipelaghi del Mediterraneo, tra cui il Liber Insularium Arcipelagy (1420) del religioso fiorentino Cristoforo Buondelmonti (1385?-1430?).
L’elenco dei portolani è numeroso. Concludiamo citando il portolano del Mediterraneo Kitab-i Bahriye (Libro della marina) dell’ammiraglio turco Piri Reis (1465?-1553?) redatto intorno al 1520.